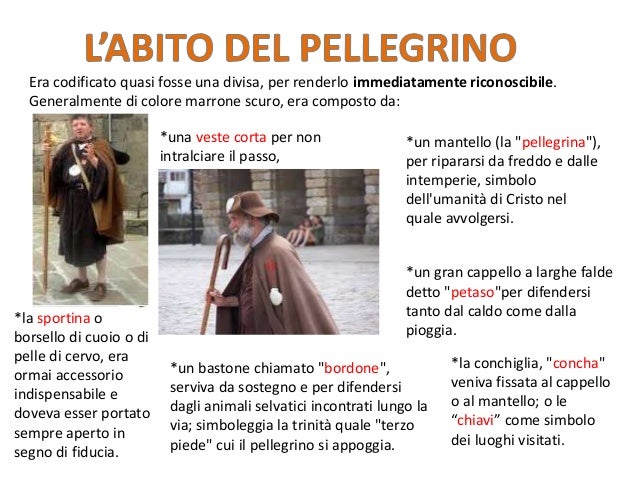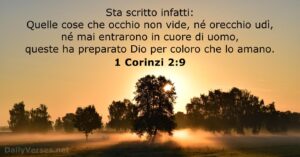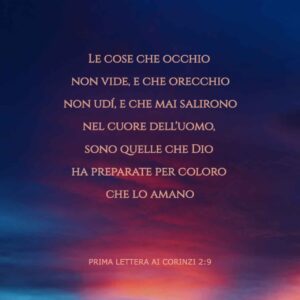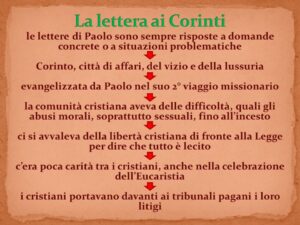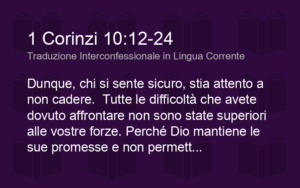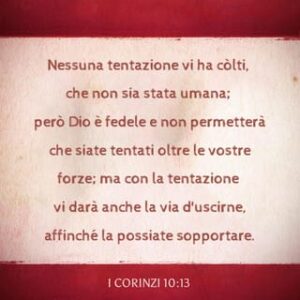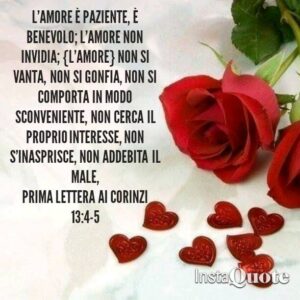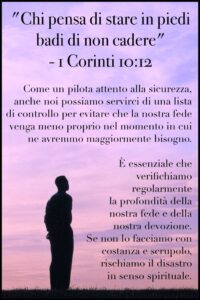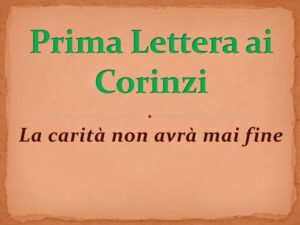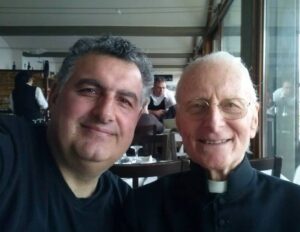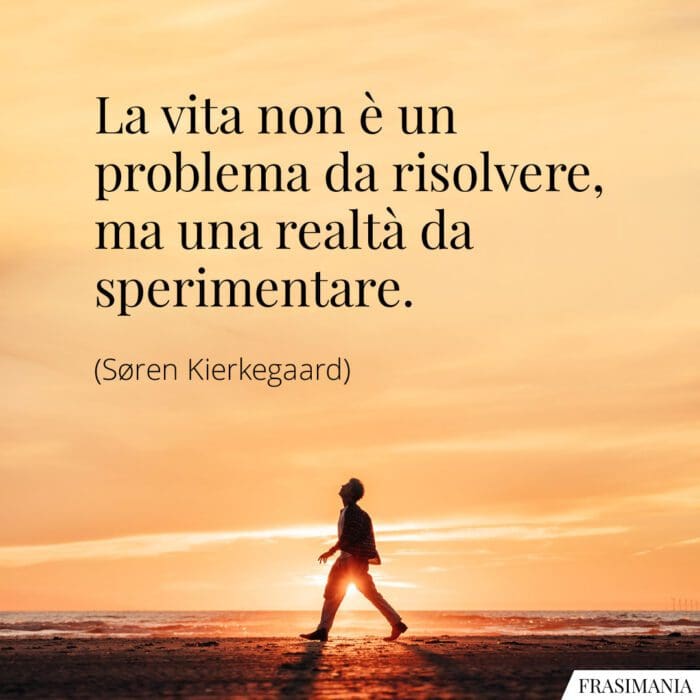KIERKEGAARD, SØREN AABYE
Filosofo e teologo danese (Copenhagen 1813 – ivi 1855).
LE VICENDE BIOGRAFICHE
Solo apparentemente la biografia di K., certo piuttosto scarna, ha un rilievo secondario: la sua vita fu pressoché interamente dedicata all’attività intellettuale, grazie all’eredità paterna, che gli consentiva una vita agiata; ma i pochi eventi fondamentali che la segnarono – il rapporto con il padre, e il terribile episodio della «maledizione di Dio» da parte di quest’ultimo, il tormentato amore con Regina Olsen, con cui egli decise di troncare il fidanzamento, i vivaci contrasti con la Chiesa protestante danese, che furono condivisi da ampi strati dell’opinione pubblica danese, tanto che i suoi funerali ebbero larga partecipazione di popolo – sono difficilmente separabili dal complesso della sua opera; né si può sottovalutare il peso dei viaggi a Berlino, in partic. di quello del 1841-42, in cui egli ebbe modo di assistere alle lezioni di Schelling. Vero fondatore dell’esistenzialismo, K. ha insomma incarnato nella sua persona il principio secondo cui «l’esistenza precede l’essenza», realizzando in una misura che forse è stata raggiunta solo da Nietzsche (personaggio insieme estremamente diverso e straordinariamente affine al suo) una strettissima integrazione di vita e riflessione filosofica, svoltasi con un ritmo febbrile in un arco di tempo assai breve. Opere principali: Om begrebet ironi (1841; trad. it. Sul concetto di ironia con riferimento costante a Socrate); Enten-eller (1843; trad. it. Aut-Aut) (➔); Frygt og Baeven (1843; trad. it. Timore e tremore); Gjentagelse (1843; trad. it. La ripresa); Philosophiske Smuler (1844; trad. it. Briciole di filosofia); Begrebet Angest (1844; trad. it. Il concetto dell’angoscia); Stadier paa livets vej (1845; trad. it. Stadi sul cammino della vita); Afsluttende uvidenskabelig efterskrift til de philos;ophiske smuler (1846; trad. it. Postilla conclusiva non scientifica alle ‘Briciole di filosofia’); Christelige Taler (1847; trad. it. Discorsi cristiani); Sygdommen til døden (1849; trad. it. La malattia mortale); Indøvelse i christendom (1850; trad. it. Esercizio del cristianesimo); fondamentali, per la comprensione della vicenda interiore di K., i Diari.
L’INTERPRETAZIONE DELLA FEDE
La riflessione filosofica e la vicenda esistenziale di K. si sviluppano in un seguito di opere ed eventi estremamente serrato, segnando un approfondimento di temi e questioni che fin dai primi scritti sono abbozzati chiaramente. Caratteristiche di fondo del suo pensiero sono per un lato un’esperienza religiosa e cristiana (anche se di un cristianesimo assai peculiare) intensissima, per la quale decisivo è il rapporto con l’esperienza pietistica settecentesca e la specifica modalità sentimentale, mistica e soggettiva che tale corrente aveva impresso al luteranesimo; per l’altro il rapporto con la cultura romantica e idealistica tedesca: con gli Schlegel e Jean Paul, con l’odiato-amato Hegel, con Schelling, che certo lo deluse, ma da cui pure trasse insegnamenti decisivi. Dalla congiunzione di queste due tradizioni nasce la cifra fondamentale della personalità di K., quella che lo caratterizza dalla prima all’ultima opera: una religiosità intensamente sentita come rapporto singolare, assolutamente individuale dell’anima del credente con Dio e l’inquadramento di essa nelle categorie della filosofia romantico-idealistica, in partic. nella coppia concettuale finito-infinito: il pietista K. sente dunque il rapporto del credente con il suo Dio come un rapporto fra finito e infinito, e dunque come un irriducibile paradosso. Questo paradosso, questa offesa alla logica (il fatto che l’uomo finito senta dentro di sé un rapporto insaziabile con l’infinito, che lo deborda e lo spinge alla negazione di sé) è poi il paradosso della stessa incarnazione del Cristo, evento irriducibile a qualunque spiegazione e documentazione storica e rispetto al quale solo il salto, continuamente rinnovato e mai completamente concluso, in cui si sostanzia la fede, può in qualche modo essere all’altezza. Altri temi fondamentali dell’opera di K., che gli conferiscono un’originalità e una modernità straordinarie, sono quelli della maschera e dello pseudonimo, entrambi legati alla sua riflessione sulla comunicazione: la vera comunicazione non può essere diretta, oggettiva; la verità essendo sempre soggettiva, essa non può essere che data attraverso un approccio complesso e poliedrico, fornendo una serie di punti di vista diversi e anche inconciliabili, che costringono così colui a cui essa è rivolta a interpretarla attivamente, a conquistarla, a essere non un passivo ricettore, ma un soggetto responsabile che sceglie, e sa di rischiare di poter fallire nel raggiungimento della verità, di poter scambiare il vero per il falso. Ma lo pseudonimo rappresenta anche un modo per immedesimarsi pienamente nell’altro e per conquistarlo, per così dire dall’interno, per far produrre a lui stesso il suo punto di vista e insieme la sua critica.
AUT-AUT
In Aut-Aut, opera pubblicata con lo pseud. di Victor Eremita, K., dopo che nella tesi di laurea sul concetto di ironia aveva già delineato, riprendendo un topos della cultura romantica, alcuni aspetti fondamentali della sua riflessione, sviluppa la famosa distinzione fra uno stadio estetico e uno etico della vita, fra i quali (donde il titolo dell’opera) esiste non un semplice passaggio, uno sviluppo, ma un salto, un’alternativa assoluta. Nel primo l’uomo ricerca continuamente il piacere immediato, unendo vita e poesia. La trattazione sul Don Giovanni di Mozart, nota anche come Diario del seduttore, in cui K. sviluppa una fine e originalissima analisi dell’opera, costituisce una parte del testo. Ma l’esistenza estetica mette capo alla noia e quindi alla disperazione. Vivendo questa non passivamente, ma come scelta deliberata, l’uomo può compiere il salto alla vita etica: vita non più di dissipazione e continuo cambiamento, ma di costanza: al seduttore succede il marito, uomo delle scelte responsabili. È qui che di nuovo compare la categoria romantico-idealistica dell’infinito: la soggettività etica è infinita, poiché è rapporto a Dio, e dunque è assoluto e libertà. Ma nemmeno lo stadio etico basta a sé stesso: l’uomo etico non può che giungere alla consapevolezza della colpa, al pentimento e dunque alla necessità di una vita non semplicemente etica, ma di fede e religiosa.
TIMORE E TREMORE
Questo ulteriore «salto» è quello che K. svilupperà nell’opera immediatamente successiva, Timore e tremore. L’opera, pubblicata sotto lo pseud. di Johannes de Silentio, è una meditazione su un episodio cruciale e terribile dell’Antico Testamento: il sacrificio di Isacco. K. si ribella contro tutte le interpretazioni che vorrebbero riavvicinare alla razionalità e all’etica il comportamento di Abramo, mancando così di cogliere il sentimento fondamentale che ha dovuto provare Abramo: l’angoscia. Estrema angoscia egli dovette provare, poiché l’ingiunzione di Dio di sacrificargli la vita del figlio violava «l’obbligazione etica», secondo cui «verso il figlio il padre ha il dovere più alto e più sacro». Né bisogna dimenticare l’amore profondo che Abramo provava per Isacco. Solo in base a queste considerazioni si può valutare la vera statura di Abramo e vederlo come «cavaliere della fede»: egli rinuncia al figlio in virtù dell’assurdo, cioè della fede nel fatto che a Dio tutto è possibile e che dunque con un prodigio potrà restituirgli Isacco, pur essendo nello stesso tempo convinto che, nella finitezza, «umanamente parlando», ciò sia impossibile. È questo il paradosso della fede, credenza nel prodigio e nella sua impossibilità che va oltre la rinuncia a noi stessi (la rinuncia è ancora qualcosa che noi possiamo decidere), mentre la fede è l’assurdo per cui la singolarità si apre all’infinito, a Dio, a qualcosa che le è assolutamente superiore. Si tratta insomma, per K., «di vedere quale enorme paradosso è la fede, un paradosso […] di cui nessun pensiero può impadronirsi poiché la fede comincia appunto dove il pensiero finisce». Confrontando poi Abramo, il cavaliere della fede, con l’eroe tragico, con Agamennone che deve sacrificare Ifigenia, K. fa rilevare come quest’ultimo abbia dalla sua tutto il suo popolo, che condivide il principio etico superiore a cui egli deve obbedire: Agamennone non è solo e non deve contraddire il «generale», cioè l’etica. Ben diversa è la posizione di solitudine assoluta di Abramo, che si trova come Singolo di fronte a Dio: «l’eroe tragico è grande per la sua verità morale, Abramo è grande per una sua virtù personale». K. può dunque rivendicare, contro Hegel, il carattere assolutamente paradossale della fede come rapporto di Singolarità e Assoluto, rapporto che non è assolutamente trattabile con la categoria della mediazione: «La fede è appunto questo paradosso, che il Singolo come Singolo è più alto del generale […] Il Singolo come Singolo sta in un rapporto assoluto all’Assoluto. Questo punto di vista non si lascia trattare con la mediazione».
IL CONCETTO DELL’ANGOSCIA
In Il concetto dell’angoscia (pubblicato sotto lo pseud. di Vigilius Haufniensis), K. continua questa sua linea di riflessione prendendo a oggetto il tema del peccato originale. Nella situazione anteriore all’angoscia (cap. 1°), l’uomo possiede l’innocenza solo nel senso che ignora la conoscenza della differenza fra bene e male, ossia è questo un momento in cui lo spirito, ancora «sognante», è immerso nel corpo e a lui unito immediatamente. Ora, proprio questa innocenza che è solo ignoranza, questo stato di pace e di quiete in cui «non c’è niente contro cui lottare», è essa stessa angoscia, che si presenta come un nulla esterno all’innocenza e che essa proietta continuamente contro di sé, così come i bambini, ancora ignari della loro libertà, vanno sempre in cerca di essa sotto forma di avventure e misteri: l’angoscia è insomma legata alla libertà che caratterizza l’uomo anche nell’innocenza. E quando Dio pone il divieto, tale divieto «angoscia Adamo poiché […] sveglia in lui la possibilità della libertà». L’angoscia non è dunque solo paura, ma smarrimento, oscuro e inconsapevole, di fronte alla libertà, al fatto cioè che la nostra esistenza è una mera possibilità, che si sporge sul baratro dell’infinito, sospesa, senza aver di essi alcuna chiara idea, fra il bene e il male. Dopo il peccato, che K. vede come passaggio dalla possibilità alla realtà (cap. 2°), questo processo assume più consapevolezza, senza che sia messo in discussione il valore dell’angoscia. Attraverso una serie di complessi e sottili passaggi, questa si svela come vera e propria formatrice dell’uomo come essere libero; essa lo educa alla possibilità, gli apre la dimensione del futuro e quindi lo porta alla vera e propria infinità: «Colui che è formato dall’angoscia è formato mediante possibilità. E soltanto chi è formato dalla possibilità è formato secondo la sua infinità». Ma tale apertura assoluta al possibile data dall’angoscia si realizza solo in quanto in essa il possibile è esperito nel suo aspetto più terribile: nella consapevolezza che in ogni momento siamo esposti all’annientamento e alla morte. Questa costante consapevolezza della morte ci stacca da ogni finitezza e ci rende veramente infiniti, aprendoci alla fede, che è, dice K. riferendosi esplicitamente a Hegel, «la certezza interiore che anticipa l’infinito». L’opera ha avuto una vastissima eco nel 20° sec., diventando in partic. uno dei punti di riferimento fondamentali della filosofia esistenzialistica (Jaspers, Heidegger, Marcel, Sartre, Ricoeur) (➔ angoscia).
LA POSTILLA
La Postilla conclusiva non scientifica alle ‘Briciole di filosofia’ è, dal punto di vista strettamente filosofico, il testo più importante di K., anche se, con la sua consueta ironia, egli lo presenta come «postilla» alle Briciole di filosofia che aveva pubblicato in precedenza. Come già in quest’opera, il pretesto polemico per la Postilla è offerto a K. da alcune posizioni apologetiche di esponenti della Chiesa luterana danese, che, di fronte alle difficoltà incontrate dalla critica storica nel dimostrare l’autenticità del libri canonici, avevano cercato di sostituire all’autorità della Bibbia quella della Chiesa. Per K. è l’occasione per portare alla massima chiarezza alcuni capisaldi della sua concezione. Nessun accertamento filologico, storico-empirico, così come nessuna dimostrazione speculativa potrà mai metter capo alla fede, poiché prove empiriche e dimostrazioni razionali si muovono nel campo dell’oggettività ed escludono il soggetto. Ora, la verità con cui ha a che fare la religione è il massimamente soggettivo: se mi interrogo su Dio e sulla fede in lui, questo non è un dubbio razionale su qualcosa di esterno a me, ma un dubbio su qualcosa che mi coinvolge in massimo grado. Nella religione la ricerca è caratterizzata da questo paradosso: che colui che cerca è coinvolto pienamente in ciò che cerca. Queste affermazioni che, anacronisticamente, si possono definire epistemologiche, e in cui certo si sentiva l’eco dell’ermeneutica di Schleiermacher, ma con una decisiva radicalizzazione e drammatizzazione, sarebbero state decisive per gran parte della riflessione filosofica novecentesca, ben al di là dei confini religiosi e anche della filosofia esistenzialistica. Ciò risulta ancora più evidente se si considera che la contrapposizione fede-conoscenza si declina per K. anche come contrapposizione fra passione e razionalità. La fede, come presenza di Dio infinito nell’uomo finito, presenza che non può che manifestarsi come negazione, assenza, è più affine all’amore o all’odio che alla conoscenza: il rapporto diretto e di insaziabile desiderio che spinge l’uomo verso Dio eccede ogni logica e anche per questo non può, nella comunicazione, che presentarsi come paradosso assoluto. Nel seguito, K. torna anche sulla distinzione in stadi (estetico, etico) delle opere precedenti, articolandola ulteriormente e distinguendo due stadi anche all’interno della religiosità. Il punto di approdo cui egli giunge, con l’esasperazione del paradosso, lo pone su un singolarissimo crinale fra fede e ateismo: l’estrema soggettivizzazione della religione e l’esasperazione del momento fideistico, visto come un salto o come una pascaliana scommessa da ripetere infinite volte, non mettono capo a nessuna certezza stabile, ma a una infinita, disperata situazione di ansiosa ricerca, in cui fede e non-fede sono in fondo l’una il presupposto dell’altra. Non è un caso dunque che l’irraggiamento del pensiero di K., avvenuto soprattutto nel 20° sec., a partire dalla traduzione tedesca delle sue opere, a cavallo della Prima guerra mondiale, si sia esteso ben al di là di quel cristianesimo, che è certo stato il centro della sua tormentosa ricerca intellettuale e di vita, ma di cui ha finito per mettere in discussione alcuni presupposti fondamentali.
Biografia
Kierkegaard, Soren Aabye
S. KIERKEGAARD
1813
Nasce a Copenhagen
1841-42
Compie un viaggio a Berlino, dove assiste alle lezioni di Schelling
1843
Pubblica Aut-Aut e Timore e tremore
1844
Pubblica Briciole di filosofia e Il concetto dell’angoscia
1846
Pubblica Postilla conclusiva non scientifica alle ‘Briciole di filosofia’
1855
Muore a Copenhagen



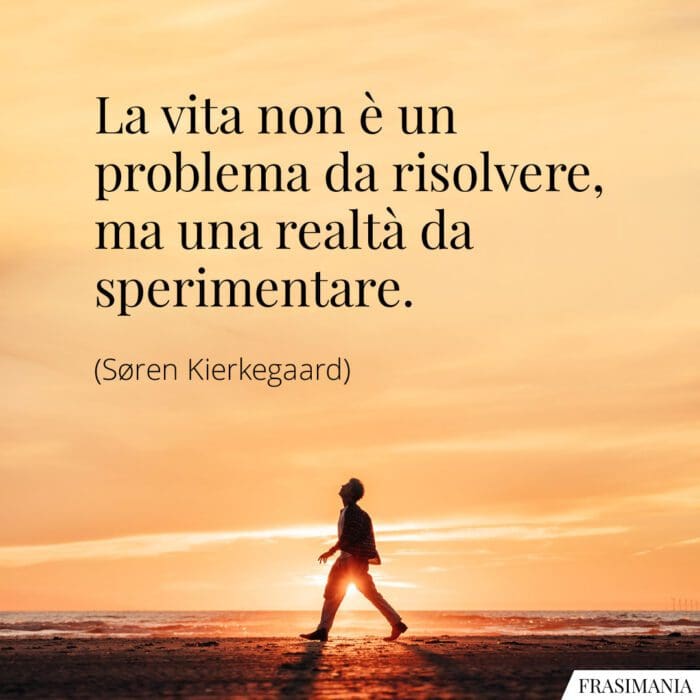






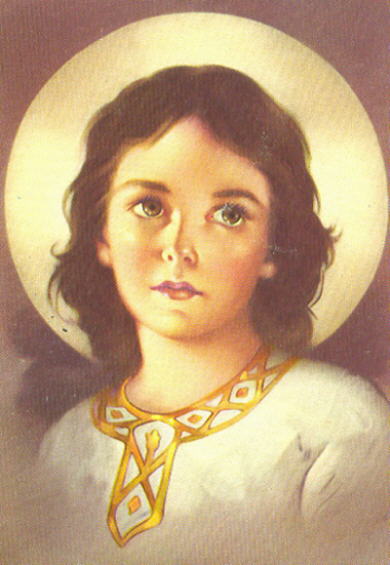

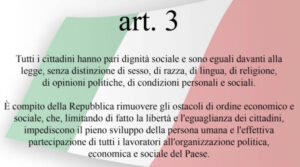

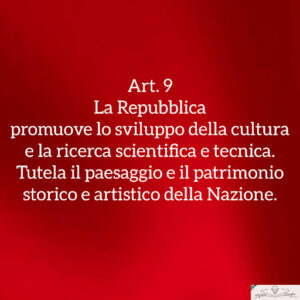
 Questa mattina Benedetto XVI ha ricevuto in udienza una delegazione del comitato olimpico nazionale italiano (il Coni) con gli atleti che hanno vinto una medaglia ai giochi olimpici e paralimpici di Londra 2012.”Mi pare che a Londra – ha detto Ratzinger nel suo saluto – abbiate conquistato ben 28 medaglie, di cui 8 d’oro! Ma a voi atleti non è stato chiesto solo di competere e ottenere risultati. Ogni attivitá sportiva, sia a livello amatoriale che agonistico richiede la lealtá nella competizione, il rispetto del proprio corpo, il senso di solidarietá e di altruismo e poi anche la gioia, la soddisfazione e la festa”.
Questa mattina Benedetto XVI ha ricevuto in udienza una delegazione del comitato olimpico nazionale italiano (il Coni) con gli atleti che hanno vinto una medaglia ai giochi olimpici e paralimpici di Londra 2012.”Mi pare che a Londra – ha detto Ratzinger nel suo saluto – abbiate conquistato ben 28 medaglie, di cui 8 d’oro! Ma a voi atleti non è stato chiesto solo di competere e ottenere risultati. Ogni attivitá sportiva, sia a livello amatoriale che agonistico richiede la lealtá nella competizione, il rispetto del proprio corpo, il senso di solidarietá e di altruismo e poi anche la gioia, la soddisfazione e la festa”. Padre Cantalamessa vede la realizzazione del Concilio e l’intervento dello Spirito Santo nei movimenti ecclesiali, nelle parrocchie, nelle nuove comunità“Gesù non ci ha dato delle parole morte (…) Ma ci ha dato delle parole vive da nutrire (…) di far vivere e di nutrire e mantenere vive nel tempo”.
Padre Cantalamessa vede la realizzazione del Concilio e l’intervento dello Spirito Santo nei movimenti ecclesiali, nelle parrocchie, nelle nuove comunità“Gesù non ci ha dato delle parole morte (…) Ma ci ha dato delle parole vive da nutrire (…) di far vivere e di nutrire e mantenere vive nel tempo”.