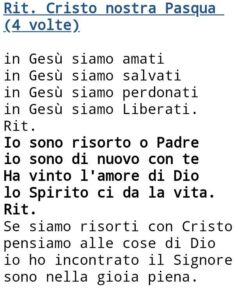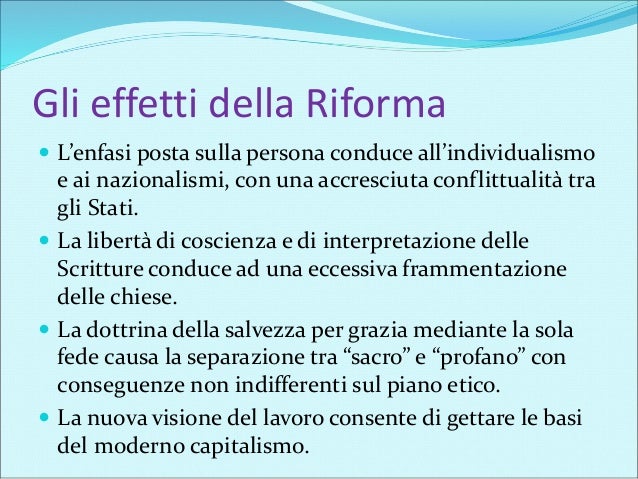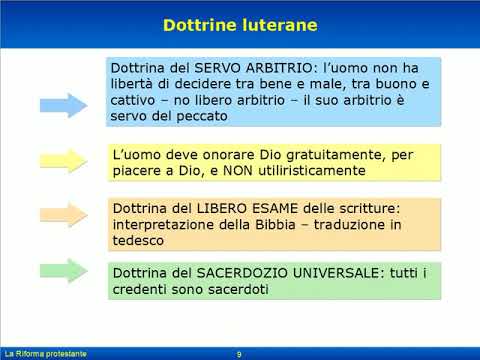Perché il papa Giovanni Paolo II è cosi amato dalla gente? Credo che sia stato il papa più vicino alle persone, egli è stato amato perché si è fatto vicino al suo popolo, ai più poveri ai più umili, egli non perdeva occasione per avvicinare tutti, salutava, abbracciava, stringeva le mani era infaticabile.
Ho incontrato personalmente il papa Giovanni Paolo II in due occasioni nella mia vita, sono stati momenti speciali in cui ho percepito tutto l’amore che aveva per gli altri e la potenza che si sprigionava dalla sua persona.
Posso testimoniare che sono stati milioni le persone che dopo la sua morte sono venuti nella Basilica di San Pietro per ricordarlo, salutarlo fare una preghiera. In questi anni è stato talmente intenso il flusso di pellegrini che sulla sua semplice ma solenne tomba non ci si poteva fermare neanche un minuto perché la fila doveva scorrere.
L’impatto che il pontificato di Giovanni Paolo II ha avuto nel mondo è stato fenomenale, era considerato da tutti una figura carismatica e uno dei pochi riferimenti morali che la nostra storia recente abbia conosciuto. Questi sono i motivi per cui la congregazione dei santi ha deciso per la beatificazione.
Molti altri miracoli ha fatto questo grande papa che come strumento di Dio si è messo al servizio dell’umanità per illuminare tutti sul cammino della salvezza.

GIACOMO INCONTRA IL PAPA GIOVANNI PAOLO 2 VIDEO
Beatificazione, 3 settembre 2000 da papa Giovanni Paolo II.